Non sono presenti prodotti nel carrello.
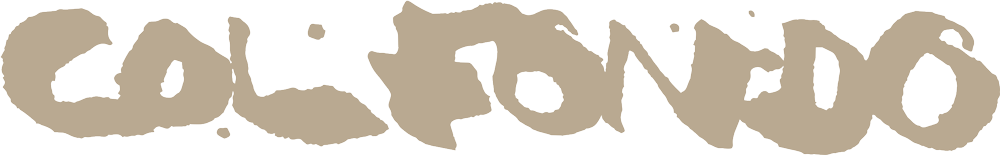
I Vini Non Filtrati di Riccardo Zanotto
La mia visione, i miei vini col fondo.
Ogni bottiglia nasce dalla mia passione per la terra e l’autenticità del vino non filtrato. Il mio viaggio è iniziato oltre quindici anni fa con il frizzante Zanotto Col Fondo, uno dei primi nel suo genere. Allora si parlava di “sur lie” – in italiano “sui lieviti” – ma insieme ad altri visionari ho voluto riscoprire “col fondo”, un termine del dialetto veneto che oggi è sinonimo di tradizione e gusto autentico. Questo vino frizzante naturale prende vita in bottiglia: la rifermentazione sui lieviti crea un fondo vivo che evolve, arricchendo ogni sorso di sapori rustici e freschi, chiuso da un tappo a corona.
Dalle colline venete scelgo uve uniche per creare vini artigianali: bianchi intensi, un raro rosso col fondo, macerati profondi e un rosato elegante. Plasmati dal territorio e dalla mia mano, offrono sapori autentici e antichi, perfetti con piatti semplici o momenti di scoperta.
Zanotto Col Fondo
Vino bianco frizzante
Non filtrato – Col fondo
Rosso Col Fondo
Vino rosso frizzante
Non filtrato – Col fondo
Rude
Vino bianco frizzante
Non filtrato – Col fondo
Nude
Vino rosato frizzante
Non filtrato – Col fondo
Dude
Vino bianco macerato frizzante
Non filtrato – Col fondo
Wild
Vino bianco frizzante
Non filtrato – Col fondo
Per saperne di più
L’Arte di Bere il “Col Fondo”: Tre Atti di una Tradizione Frizzante
C’era un tempo in cui il “col fondo” non era un capriccio alla moda, ma un gesto semplice, quasi scontato, come spezzare il pane. Nelle vecchie osterie era uno dei due vini serviti: tranquillo o frizzante col fondo, entrambi figli della terra e del lavoro di ogni giorno.
Primo atto: la purezza
Chi lo faceva, i contadini che coltivavano le viti, prendeva la bottiglia – un po’ opaca, velata dai lieviti – e la maneggiava con cura, senza agitarla. La versava in una caraffa di vetro, di quelle semplici da cucina, ben diverse dai decanter raffinati dei salotti. Lo faceva piano, travasando solo il vino limpido e lasciando il torbido sul fondo della bottiglia, come una scelta naturale. Un inchino alla semplicità.
Secondo atto: la ribellione
Poi il tempo ha rimescolato le carte. I “cultori”, nuovi cantori del “col fondo”, hanno abbracciato il torbido. Scuotono la bottiglia con un gesto misurato, come a risvegliare un’antica forza, e versano il vino in calici larghi. Qui i lieviti si muovono, vivi, e sprigionano profumi di crosta di pane, fiori di campo, terra dopo la pioggia. È un’esplosione rustica, un sorso che sa di temporale. Un canto alla natura che non si piega.
Terzo atto: la libertà
E poi c’è chi non sceglie né l’uno né l’altro, ma improvvisa. Stappa e versa, senza regole, senza attese. Ogni bicchiere è un azzardo: il primo, fresco e vivace come un soffio di vento; l’ultimo, denso e indomabile come un ricordo che non svanisce. Un brindisi alla vita che sorprende.
Tre modi di bere il “col fondo”, tre modi di stare al mondo. Una commedia in tre atti, rustica e schietta, dove il vino è il narratore e la tavola il palcoscenico. Perché il “col fondo” non è solo vino: è un racconto, un’eco di giorni lontani, un respiro di una terra che tiene strette le sue radici.

I Vini Ancestrali col Fondo: una tradizione italiana con echi europei
I “vini col fondo” sono un tuffo in una tradizione affascinante, un ritorno a metodi di vinificazione che sembrano quasi dimenticati, come strappati all’oblio del tempo. Si tratta di vini frizzanti naturali, prodotti con il cosiddetto “metodo ancestrale”, o, come dicono i francesi Pétillant Naturel (Pét-Nat) o Sur lie, che prevede una fermentazione spontanea in bottiglia, lasciando i sedimenti – il “fondo” – a conferire torbidità e un carattere rustico e unico. Sebbene la loro identità sia fortemente legata al panorama vinicolo italiano, in particolare con denominazioni e pratiche specifiche, il concetto di vini rifermentati in bottiglia e non filtrati (o non sboccati) non è un’esclusiva del Bel Paese.
Spesso legati al territorio del Prosecco, dove l’uva Glera la fa da padrone, questi vini non sono un’esclusiva delle colline venete. Li troviamo in Emilia-Romagna con il Lambrusco, in Piemonte con Barbera o Grignolino, o in Friuli con Ribolla Gialla. Sono un tesoro sparso qua e là, ovunque la memoria contadina resista. Similmente, in altre nazioni europee con una ricca storia vitivinicola, come la Francia (soprattutto nella Loira e in altre regioni), la Spagna e, in misura minore, altre zone con una produzione artigianale, si possono trovare vini che seguono principi simili e presentano un deposito di lieviti. Questi vini riflettono una filosofia produttiva affine, spesso orientata verso una maggiore autenticità e un intervento minimo.
Le uve più usate variano: Glera nella zona del Prosecco, Malvasia o Trebbiano tra i bianchi, Sangiovese o Lambrusco tra i rossi. Serve un vitigno con buona acidità e un profilo che si sposi con la rifermentazione. Quanto alla tecnica, dopo una prima fermentazione in acciaio o cemento, viene imbottigliato prima che tutti gli zuccheri si trasformino in alcol. È qui che avviene la magia: in bottiglia, i lieviti naturali continuano il loro lavoro, creando bollicine fini e lasciando sul fondo un sedimento che è il cuore pulsante di questi vini. Tradizionalmente, si imbottiglia in luna crescente – in primavera – per favorire le bollicine, contando sugli zuccheri naturali e i lieviti indigeni. Oggi, la fermentazione può essere fermata col freddo, con lieviti e zuccheri aggiunti prima dell’imbottigliamento per guidare il risultato. In ogni caso, la natura fa il suo corso: in bottiglia, la rifermentazione crea bollicine e sedimenti in 30-60 giorni, anche se alcuni aspettano mesi per un gusto più ricco. Il tappo a corona domina, pratico e resistente, per un vino che non saprà mai “da tappo” e che migliorerà con gli anni se tenuto al fresco in cantina. Meno comune è il tappo a fungo in sughero con gabbietta, obbligatorio però per il Prosecco DOC e DOCG, secondo i loro disciplinari.
E poi c’è il rito finale: berlo torbido, agitando i sedimenti per un sorso pieno e selvatico, o decantarlo con cura per una limpidezza che sussurra eleganza – due anime dello stesso vino, un’eco viva della terra che lo ha generato.







